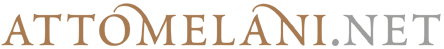L’inverno esistenziale del Crazy Horse
di MONALDI e SORTI
Considerazioni estemporanee leggendo “Dieci vite in una. Romanzo ispirato alla vita di una ballerina del Crazy Horse” di Gérard Journo
Cento pagine dalla scrittura di piano estetismo morale, per raccontare le dieci vite di un’anziana donna, morta da poco in una casa di riposo romana della comunità ebraica dopo un’intera esistenza trascorsa tutta nel perimetro esistenziale del Crazy Horse.
Il Crazy Horse è il famoso locale parigino di spogliarello aperto negli anni ’50 da quell’Alain Bernardin la cui nota caratteristica era lo sguardo in perenne putrefazione, tanto da esalare odore di decomposizione avanzata perfino dalle foto, perfino oggi, a trent’anni da quando si tolse la vita con un colpo di pistola alle soglie degli ottant’anni.
E mentre la lettura pomeridiana scorre senza intoppi, soffermandosi con piacere per enunciare ad alta voce ai famigliari intenti ad altro un paio di perle stilistiche di particolare maturità letteraria di Journo, si annusa nelle pagine un’aria autunnale già nota, ma dove? Un autunno senza le gioie colorate che l’Amante Perfetto ripone nel giallo e rosso delle foglie, nel blu violaceo e patinato delle bacche mature, per strappare ai nostri distratti pensieri il deposito frettoloso di un piccolo, sorridente “Ti amo anch’io” su quei colori e quelle forme. No, l’autunno di questo romanzo è, fin dall’infanzia della protagonista, velato di quel grigio tramonto senza fine, senza colori né odori, l’autunno “verbaut” delle giungle di cemento, materiali o (im)morali che siano.
Dove si gustava già questa poco desiderabile staglione esistenziale? Forse nella saga degli Ephrussi narrata da Edmund De Waal partendo dalla sua collezione di famiglia? Pure la storia della ballerina del Crazy Horse parte da un oggetto d’arte. Due connubi tra collezionismo e decadente memoria à rebour bergsoniana inaugurata da Marcel Proust con la madeleine che, affogando nel tè, riporta l’autore indietro alla soffocante infanzia di asmatico rampollo in perenne credito di baci materni che soli potevano conciliargli il sonno. Proust e De Waal, sì, autunnali, ma lì i colori ci sono, pur sommessi; in De Waal già dal titolo: Un’eredità d’avorio e d’ambra. Malinconici. Dieci vite in una invece non è malinconico, perché non è dolce. L’effetto, del tutto soggettivo, che ne emerge è di una protagonista dura, fredda, che depone volontà e cuore nella paglia, e sulla paglia costruisce, con metodo e determinazione: un ritratto tanto poco romanzesco quanto tuttavia plausibile per una spogliarellista. È incredibile la capacità di Gérard Journo di ritrarla come, si sospetta (e si teme per lei), ella sia stata davvero. Nessun afflato attraversa la sua vita, su cui la storia è scorsa come acqua cristallina su un sasso dello stagno, levigandolo senza mai renderlo qualcosa di più di quello che è. Un sasso levigato, un ciottolo. Dall’inizio alla fine. Anche quando dice di amare, o quando soffre per l’abbandono del putrescente Bernardin. Mistero dell’anima umana. Eppure così credibile. Nella protagonista di un romanzo biografico al femminile ci si aspetterebbe sempre una figura eccezionale, che si desidererebbe incontrare. Ma la realtà è diversa. E questa spogliarellista è verosimile, spogliarellista dentro e fuori, senza che mai emergano ipotetici sublimi anfratti emozionali forse compressi in fondo all’oceano dell’anima.
Quindi no, la reminiscenza non c’entra col romanzo di De Waal. Poi, finalmente, il lampo: La settima stanza, il film della premiatissima regista Márta Mészáros (dall’Orso d’Oro del 1975 al premio alla carriera European Film Awards 2021, passando per Cannes). Anche lei ungherese come la ballerina del Crazy Horse protagonista del romanzo di Journo.
Una pellicola vista tante volte in casa che ormai le nuove generazioni, alla proposta di rivederla, nicchiano regolarmente con l’obiezione “È triste”. Triste? È piuttosto storia – e vademecum – della vittoria sulla congenita tristezza: dai canti di Moni Ovadia fino allo sferragliare del treno per Auschwitz, quando conduce la protagonista alla libertà della “settima stanza”, quella che passa per la Croce. Un giorno lo riscopriranno. Ma ci sono stati anni in cui, ogni 9 agosto, erano i ragazzi stessi a portare giù dalla loro libreria il dvd del film. La settima stanza, infatti, racconta di Edith Stein.
È in quel film che si respira lo stesso autunno, cementoso e omnipervasivo, di Dieci vite in una.
Sette stanze per sette anni: tanto ha penato la regista ungherese per trovare qualcuno disposto a finanziare la sua idea cinematografica.
Edith ci spiega nel film le sette stanze: la prima stanza racchiude un’anima incapace di sentire e parlare, prigioniera del mondo esterno; allora inizia a interrogarsi, a conoscersi interiormente giungendo nella seconda dimora, dove l’anima lotta contro le tentazioni. Nella terza stanza l’anima si purifica tramite la meditazione, nella quarta l’immaginazione affolla la mente e la conoscenza e la memoria sono un peso di difficile sopportazione. Nella quinta dimora il mondo profano svanisce e l’anima rimane libera da ogni costrizione. La sesta dimora è dove l’anima lascia tutte le tentazioni e aspetta di accedere alla settima stanza, che però ancora non conosce.
Alla fine del film Edith, la strepitosa attrice rumena Maia Morgenstern, la Madonna di Passion, raggiunge la settima stanza: la camera a gas di Auschwitz. È colma di un bagliore accecante, la “luce buia” carmelitana di san Giovanni della Croce, festeggiato due giorni fa nel calendario. Oltre il bagliore s’intravede la madre (Adriana Asti) mentre l’abbraccia. L’autunno “verbaut” è scomparso per sempre. Edith ha vinto. Nella camera a gas. La follia della Croce. Ciò che per il mondo è follia, anzi, forse più precisamente se vogliamo tradurre l’originale greco, idiozia. Anche oggi i cattolici sono derisi come idioti ogni giorno a tonnellate: basti dare un’occhiata, sui profili social di pennivendoli vari, a ogni solennità religiosa, specie se mariana.
Le sette stanze sono di Santa Teresa d’Avila, la cui biografia fece esclamare alla filosofa ebrea, atea e allieva di Husserl, Edith Stein, “Questa è la verità!”. Un po’ come accaduto a noi in famiglia con i dieci volumi di Maria Valtorta. Quando trovi la verità vendi tutto e la segui. Se vuoi.
Edith si fece carmelitana: ecco un nesso che ci unisce da un lontano 8 dicembre 2008, quando, arrivati a Roma per la fiera Più libri più liberi, dove ogni anno, quando ancora si teneva a Palazzo dei Congressi all’Eur, c’incontravamo in incognito con l’Imprimatur fan club. In una pausa andammo con i nostri amici a Santa Maria della Vittoria, chiesa provinciale dei carmelitani: in quel giorno, festa solenne dell’Immacolata Concezione (e di alcuni onomastici di famiglia), decidemmo in sei di venire rivestiti dello scapolare di Nostra Signora del Monte Carmelo, che già aveva fatto capolino nei nostri romanzi tra gli effetti personali di Atto Melani. E pensare che ancora entrando in chiesa sparlavamo di certi passi sconcertanti del Vangelo (esattamente tre anni dopo, l’opera valtortiana ci avrebbe chiarito ogni dubbio).
Edith entrò nel carmelo di Colonia, la città dove Duns Scoto, il vittorioso promotore dell’Immacolata, trovò la morte giovanissimo, dopo aver pestato i piedi a mezza Chiesa (di ieri e di oggi, speriamo non di domani) con la dimostrazione, a tutt’oggi teologicamente irrefutabile, della concezione senza macchia della madre del Redentore. Duns Scoto, l’altra nostra passione. Altra intersezione di storie e di vite. Il film del 2011 su Duns Scoto fu un successo tale, tradotto in tante lingue, che da allora regista e attori lavorano a malapena. Senza ironie: certi temi, se riesci a farli passare sotto al naso dei potenti della terra (cosa che solo per autocensura avviene così di rado), ti costano caro. Hanno pagato caro loro, come aveva pagato carissimo Duns Scoto: alla ricognizione della salma, certe escoriazioni al capo e alle dita, fecero sorgere il sospetto che lo avessero sepolto vivo, come fu sepolto vivo ad Auschwitz l’altro promotore dell’Immacolata: padre Massimiliano Kolbe (francescano come Scoto, martirizzato ad Auschwitz come Edith). Non è forse l’Immacolata che per sempre seppellirà vivo satanasso e i suoi? Così, in vista dell’inesorabile, l’inferno si sfoga.
Tornando al romanzo in questione, l’autunno senza colori è l’orizzonte in cui la spogliarellista ungherese nasce e muore. Non ne vuole uscire, anche se infelice, né si pone mai domande veramente esistenziali. Vive in una mera dimensione estetica, come se escludesse a priori la possibilità di una via di fuga dal suo perimetro a luci rosse. Forse, semplicemente, non vuole. La volontà è tutto, lo diceva anche Duns Scoto contro Tommaso d’Aquino, cosa che gli costa ancor oggi l’antipatia di certi teologi intellettualisti (e forse poco volenterosi). Ma il primato della volontà sull’intelletto è ribadito dal Cielo – per chi ci crede – in tutti i dettati mistici (e nella Divina Commedia, che solo dei ciechi possono definire filotomista). La ballerina del Crazy Horse chiude la sua vita lunga quasi un secolo nel freddo pervasivo di una panchina alla quale l’ha condotta il treno inesorabile degli anni. E il sapore di fiele di quelle pagine s’intreccia, a leggerlo, con lo stridore del convoglio che nel film sferragliava sulle note di Moni Ovadia.
Il medesimo autunno di fiele pervade La settima stanza, ma Edith, entrando stretta alla croce in quella stanza spoglia, vi trova la Pienezza: “Sotto alla croce ho compreso… ma con la sola ragione non potrà mai essere compreso”. Di nuovo Duns Scoto.
Grazie a Gérard Journo per averci regalato questo multiforme viaggio, buttato giù immersi nell’immacolato biancoblu di una serata nevosa.